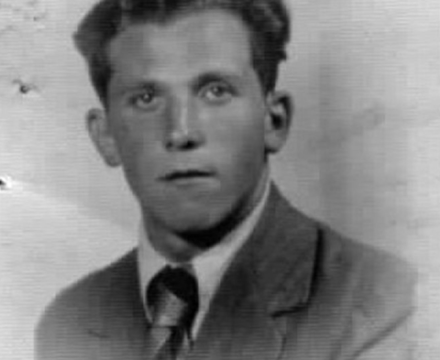Orazione ufficiale di Raffaella Romagnolo
Proponiamo qui il testo dell’orazione ufficiale pronunciata dalla scrittrice Raffaella Romagnolo in occasione dell’81° Anniversario dell’eccidio della Benedicta. La medesima orazione sarà pubblicata nel prossimo numero della rivista dell’Isral, “Quaderni di storia contemporanea”, una delle più qualificate pubblicazioni della storiografia contemporanea. Ringraziamo l’autrice, la presidenza dell’Isral e la direzione della rivista per la cortese collaborazione.

6 aprile 2025 – Sacrario dei Martiri della Benedicta
Orazione ufficiale
Testo di Raffaella Romagnolo
Innanzitutto vorrei ringraziare l’Associazione Memoria della Benedicta per l’invito, onore per me grandissimo, e poi proprio quest’anno, che è l’ottantesimo dalla Liberazione.
Noi umani siamo particolarmente affezionati agli anniversari tondi, ne facciamo sempre occasione di riflessione e bilancio. L’anniversario della Benedicta – 7 aprile 1944 – per un fatto di calendario precorre, anticipa sempre di un anno il bilancio, il significato che attribuiamo al 25 aprile 1945. Lo scorso anno della Benedicta abbiamo celebrato l’ottantesimo. Immagino che sia accaduto qualcosa di simile 80 anni fa. Immagino, cioè, che la Benedicta abbia brillato come una torcia nella lunga notte che andò dal 7 aprile ‘44 al 25 aprile’45. Certo i partigiani e le partigiane combattenti la tennero bene a mente, la Benedicta, fece loro da monito e da carburante, tenne alti i cuori, e così ancora io la vedo oggi, la Benedicta, a 81 anni di distanza, come una luce che indica la strada.
Comincio col dire che la Benedicta è qualcosa che ci riguarda direttamente, noi che siamo qui, intendo, che questa mattina abbiamo puntato la sveglia presto e siamo saliti fino a queste terre alte tra Piemonte e Liguria, direzione monte Tobbio.
L’altro giorno scendevo in auto da Cassinelle verso Molare, e l’ho visto, il Tobbio, e non me lo aspettavo. Non ci passo mai, da quelle parti, io abito a Rocca Grimalda e il Tobbio lo vedo tutti i giorni dalla finestra di casa mia. Be’, scendevo da Cassinelle e a una svolta l’ho visto e ho pensato ai tanti luoghi dai quali il Tobbio si vede, dalla Liguria e dal Piemonte, per esempio tornando da una gita. In autostrada si vede benissimo dalla bretella autostradale, all’altezza di Novi Ligure. Oppure tornando da una gita in montagna, sempre in autostrada, e lui è lì, con i suoi contrafforti quasi alpini, la sua sagoma inconfondibile, la sua storia di lutti, il suo stare a mezza strada tra Liguria e Piemonte, più ponte che spartiacque. E allora l’altro giorno, scendendo da Cassinelle verso Molare, ho pensato: è la nostra montagna sacra. E se il Tobbio è la nostra montagna sacra, allora questo nostro di oggi è davvero un pellegrinaggio, laico e religioso insieme, sicuramente politico, fatto col corpo e con la mente, come ogni vero pellegrinaggio, che non è una gita di piacere. La meta è un luogo, questo, dove la primavera stenta ad arrivare, dove la primavera è ancora inverno, ai piedi del monte Tobbio. E se questo è un pellegrinaggio, allora, forse, la mia finirà con l’essere un’orazione nel primo senso del dizionario, che è quello di “preghiera”.

Anche se non l’abbiamo fatto a piedi, il pellegrinaggio, ma siamo saliti comodamente in auto o in pullman, ciascuno di noi ha sperimentato nel corpo il disagio del freddo, nella mente il disagio dell’allontanamento da casa, dalle abitudini piacevoli della domenica mattina, e anche il disagio dell’isolamento in luoghi impervi e quasi disabitati. E ognuno di noi, salendo, questa mattina si è detto: “pensa a all’inverno del 1944, qui”. Cioè, ognuno di noi, col corpo e con la mente, ha ricordato, ha fatto memoria. Un ricordo, una memoria in forma di immaginazione, naturalmente, perché nessuno di noi c’era, qui, nell’inverno del 1944. Un dettaglio, questo, da tenere a mente.
La Benedicta ci riguarda, dicevo, riguarda noi che siamo qui questa mattina, perché apparteniamo tutti a questi luoghi tra Piemonte e Liguria, paesini, paesoni, cittadine e Genova, certo. E 81 anni fa questi luoghi che sono i nostri hanno perso qui un’intera generazione. Centinaia e centinaia e centinaia tra mitragliati sul posto o uccisi lentamente nei campi di sterminio: qui, non c’è famiglia che non abbia perso qualcuno.
Tutti noi abbiamo esperienza di come un lutto in famiglia modifichi e ridefinisca l’equilibrio, la natura di una famiglia. Non siamo più quelli che eravamo, dopo un lutto. Sforziamoci allora di immaginare una perdita così gigantesca. Una generazione. Di ragazzi. Questa perdita ha definito ciò che siamo. Questa perdita ha definito l’identità delle nostre comunità. Noi siamo, dopo l’aprile 1944, noi siamo inevitabilmente diventati “quelli della Benedicta”. Il nostro onore. Il nostro onere.
Io non sono nata qui. La mia famiglia non ha avuto nessun caduto alla Benedicta. Ma siamo arrivati a Ovada che io andavo alla scuola materna e se cresci in questi posti, l’ho già detto altre volte, se vieni su in questi posti la Resistenza ti viene addosso come una montagna. Se poi, per caso o per destino, ti scopri scrittrice, la montagna la devi affrontare. Se decidi di scrivere della gente che è diventata la tua gente e dei posti che sono diventati i tuoi posti, la montagna la devi affrontare. Attenzione, però. Io vorrei chiarirlo bene questo punto. Non si scrive di ciò che si conosce. Si scrive per conoscere, per capire, per indagare dentro qualcosa che, a uno sguardo distratto o frettoloso, appare opaco, indistinguibile dal resto. Provincia. Ma come tante. Campagna. Come tante. Terra di nessuno, sospesa tra Piemonte e Liguria, e quindi forse senza un’identità immediatamente afferrabile. Si scrive inseguendo il mistero sotto le apparenze. E più io scrivevo, più il mistero si dipanava e intravedevo, sotto, qualcosa di specifico, di caratteristico, di unico, qualcosa che ha a che fare con l’identità. E più scrivevo e più mi convincevo che questo qualcosa, questa ferita identitaria, è appunto la Benedicta. Noi siamo quelli della Benedicta.
La nostra ferita identitaria. Il nostro trauma. Non accidentale, frutto di violenza. Ci sono, in questa vicenda, vittime, e ci sono carnefici. La parte giusta della Storia e la parte sbagliata.

Vittime. Carnefici. Far giustizia non è prerogativa esclusiva dei tribunali. Se si tratta di affrontare un trauma, non bastano i tribunali. Raccontare può essere un modo, imperfetto e approssimato come ogni cosa umana, di medicare le ferite e di fare giustizia. Funziona così da millenni. Quando Omero racconta la guerra di Troia, in qualche modo fa giustizia. Per le vittime, naturalmente. Giustizia per Patroclo, per Ettore, per Priamo costretto a implorare l’assassino del figlio, giustizia persino per Achille, vittima a suo modo. La Benedicta, io ne sono convinta, è la nostra Iliade.
Però la nostra Iliade è anche il più grande massacro di partigiani della storia nazionale. Lo ripeto: il più grande massacro di partigiani della storia nazionale.
E allora, forse, a 81 anni dai accadimenti, quando tutte quelle che potevano essere le tensioni interne a quegli anni lontani si sono sciolte in un nocciolo duro di fatti – vittime, carnefici, la parte giusta della Storia, la parte sbagliata – forse è venuto il momento per cui questa ferita nostra non sia più solo nostra, ma parli al Paese intero e sia per tutti una torcia, e soprattutto adesso che la notte incombe e si annuncia lunga e buia.
Certo 81 anni sono tanti. I testimoni – che potenza la loro parola, che gratitudine dobbiamo loro – i testimoni sono rimasti pochissimi e quasi centenari. Quindi la Benedicta è, anagraficamente, faccenda nostra, di noi che siamo vivi qui e ora. E la domanda è: che vogliamo farcene di questa memoria? Che poi è la domanda più generale, visto che la Benedicta, come dicevo prima, fa da battistrada: che vogliamo farcene del 25 aprile e della Resistenza? Riformulo: cosa resta, oggi, della Benedicta, del 25 aprile e della Resistenza?
La domanda è obiettivamente difficile, da togliere il fiato, ma vi confesso che a me la risposta viene facile: è rimasta la Costituzione repubblicana e antifascista.
Bella tutta, la Costituzione, ma l’orazione ha da essere breve e quindi scelgo solo due punti che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo per la verità compare poco nella Costituzione repubblicana e antifascista, concentrata com’è a restituire ai cittadini e alle cittadine italiane i diritti che il totalitarismo fascista aveva loro sottratto. Mi riferisco al concetto di “dovere”.
Lo trovo nell’articolo 4, quello del diritto al lavoro. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Bene, l’ho detto, la Costituzione è innanzitutto la Costituzione dei diritti. Ma poi aggiunge, l’articolo 4: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
Ecco, ogni volta che leggo questo passaggio, mi sembra di vederla la società per cui si è combattuto su queste terre alte. Una società dove ciascuno è coinvolto in prima persona, dove ciascuno collabora come può al progresso della collettività, una collettività di individui che agiscono per se stessi e contemporaneamente come parte di un tutto. Mi viene in mente un bel passaggio del discorso di fine anno del presidente Mattarella. Sono andata a ricercarlo e ve lo leggo. Il presidente si è soffermato sul significato dell’essere patrioti.

Patriottismo è quello dei medici dei pronto soccorso, che svolgono il loro servizio in condizioni difficili e talvolta rischiose. Quello dei nostri insegnanti che si dedicano con passione alla formazione dei giovani. Di chi fa impresa con responsabilità sociale e attenzione alla sicurezza. Di chi lavora con professionalità e coscienza. Di chi studia e si prepara alle responsabilità che avrà presto. Di chi si impegna nel volontariato. Degli anziani che assicurano sostegno alle loro famiglie.
Questo è il luogo dove una generazione ha preso in mano la propria vita e l’ha messa in gioco al servizio di un bene individuale, certo, ma anche collettivo. Traguardando, immaginando un’idea di comunità nuova e diversa da quella che quei ragazzi avevano conosciuto nella loro vita, una comunità rispettosa dei diritti individuali e consapevole di sé stessa come un organismo in cui tutto si tiene.
L’altro articolo che sta nella Costituzione repubblicana e antifascista, e che quindi è il frutto del sacrificio dei martiri della Benedicta, è la loro eredità, è l’articolo 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali volte a tale scopo.
Questa è una “dichiarazione di pace”. Questa “dichiarazione di pace” è l’eredità dei partigiani e delle partigiane combattenti, dei torturati, dei deportati, dei trucidati, delle staffette, dei contadini che sfamarono i ragazzi della Benedicta, delle madri, delle sorelle che salirono a ricomporre i corpi.
Allora, in questa notte che è alle porte, permettetemi di tornare alla domanda di prima. Cosa vogliamo farcene di questa memoria?
Perché a me pare che stiamo dimenticando. Quando tre anni fa, si era all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, venne attaccata la città di Mariupol, il presidente Zelensky, rivolgendosi in collegamento alla Camera dei Deputati per avere aiuti, scelse un esempio per farsi capire e risvegliare le coscienze. “Mariupol è come Genova” disse. Quanti nostri deputati capirono cosa intendeva? Quanti, capimmo? Quanti avevano conservato memoria, non individualmente, collettivamente, nella coscienza pubblica, di cos’è stata la guerra? Di cos’è stato essere civili sotto le bombe?
Se c’è un titolo che mi piacerebbe dare a questa mia orazione è “Elogio del senno di poi”. Vorrei che esercitassimo il senno di poi. L’abbiamo provata la guerra. Noi della Benedicta, più degli altri.
Abbiamo anche dimenticato, mi pare, che la guerra arriva con parole alate.
Il 26 novembre 1911 il grande poeta Giovanni Pascoli tenne un discorso al teatro di Barga a sostegno dell’invasione italiana della Libia. Invasione militare, coloniale. Il discorso comincia così: “La grande proletaria si è mossa”. E’ un endecasillabo a maiore, il verso principe della poesia italiana, il verso capace di piantarsi nel cervello con la forza degli accenti e della tradizione poetica. Nel mezzo del cammin di nostra vita è un endecasillabo a maiore, per dire.
La guerra arriva con parole alate.

Il 4 maggio 1915 il grande poeta Gabriele D’Annunzio arriva a Genova da Parigi. La prima guerra mondiale è già in corso. “L’inutile strage” la definirà poi il papa Benedetto XV. L’Italia, per il momento, ne è fuori. C’è un forte dibattito tra interventisti e neutralisti. Il giorno successivo, 5 maggio 1915, cinquantacinquesimo anniversario dall’impresa dei Mille Gabriele D’annunzio, acceso interventista, tiene un discorso allo scoglio di Quarto. La folla è impressionante, soprattutto giovani, e il discorso di D’Annunzio straordinariamente efficace. “Tutto ciò che siete, tutto ciò che avete, e voi datelo alla fiammeggiante Italia” dice ai ragazzi venuti ad applaudirlo. Parole alate. Riscrive per loro il discorso evangelico delle beatitudini. “Beati i misericordiosi, perché avranno da tergere un sangue splendente, da bendare un raggiante dolore”. Parla ancora parole alate, D’Annunzio, anche nei giorni seguenti. Parla a Roma, per strada, agli studenti dell’università, dalla ringhiera del Campidoglio e tutti i suoi discorsi vengono trascritti, impaginati e prontamente stampati dal famoso editore Treves con il titolo “Per la più grande Italia”. Il volume contiene in chiusura la dichiarazione di guerra all’Austria, datata 23 maggio 1915. Diciotto giorni dopo il discorso di Quarto.
La guerra arriva con parole alate, e spesso sono parole di menzogna. Allo scoglio di Quarto D’Annunzio aveva proclamato: “risorgono gli eroi dalle loro tombe (…) dell’arme si riarmano, delle lor bende funebri noi rifaremo il bianco delle nostre bandiere”. Aveva evocato gli spiriti dei garibaldini. La guerra arriva con parole alate e usando i morti, facendo dire ai morti ciò che non si sarebbero mai sognati di dire. Si chiama uso politico della Storia.
Le folle lo ascoltarono. Volontari a migliaia. Poi furono le trincee, l’inutile strage, da cui venne, come un frutto avvelenato da una pianta guasta, altra immane distruzione, il totalitarismo, la seconda guerra mondiale, Auschwitz, la Benedicta, Hiroshima.
Oggi a me pare che parole alate raccontino sui giornali, in televisione e sui Social l’opportunità economica della guerra, la necessità della guerra, l’inevitabilità della guerra. Addirittura, in qualche caso sciagurato, la seduzione estetica della guerra. Penso ai nostri morti su queste montagne e davvero in chiusura la mia orazione si fa preghiera. Perché vedo un rischio: che il passato custodito in queste terre alte non sia più memoria attiva e costruttiva di benessere individuale e armonia sociale, ma strumento di propaganda.
Eppure l’eredità della Benedicta è chiara, non possiamo proprio sbagliarci al riguardo, ed è scritta nell’articolo 11 della Costituzione repubblicana e antifascista. L’Italia ripudia la guerra. Il resto sono chiacchiere. Forse interessate. Di sicuro pericolose.