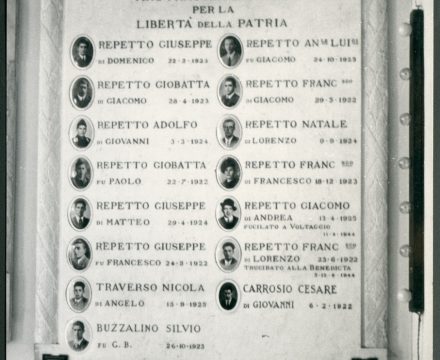Chi Siamo

Il Presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Sen. Daniele Gaetano Borioli
L’Associazione Memoria della Benedicta è una associazione senza scopo di lucro, composta dalla Provincia di Alessandria, dalla città Metropolitana di Genova, dal Comune di Alessandria, di Genova, di Bosio, di Novi Ligure, di Ovada e da più di 40 piccoli comuni siti tra la Provincia di Alessandria e Genova.
Inoltre fanno parte della nostra Associazione gli l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ILSREG) e l’ istituto per la storia della resistenza e della societa’ contemporanea in provincia di alessandria “Carlo Gilardenghi” (ISRAL).
L’ANPI provinciale di Alessandria e quella di Genova.
L’ANED sezioni di Genova e Alessandria.
Il consiglio direttivo vede attualmente in carica:
Rappresentante per la Provincia di Alessandria Daniele Borioli
Rappresentante per la Città metropolitana di Genova Laura Repetto
Rappresentante per il Comune di Alessandria Gian Paolo Lumi
Rappresentante per il Comune di Genova Arianna Viscogliosi
Rappresentante per il Comune di Ovada Antonio Di Cristo
Rappresentante per il Comune di Novi Ligure Stefano Leardi
Rappresentante per ISRAL Mariano Santaniello
Rappresentante per ILSREG Giacomo Ronzitti
Rappresentante per ANPI Genova Massimo Bisca
Rappresentante per ANPI Alessandria Roberto Rossi
Il Presidente attualmente in carica è Daniele Borioli
Il vice-presidente è Giacomo Ronzitti
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci è Stefano Persano, sindaco di Bosio
Tutta una serie di volontari e collaboratori rendono possibili con il loro impegno e la loro generosità, le attività che l’Associazione organizza.

Alcuni dei collaboratori dell’ Associazione Memoria della Benedicta ad Albera Ligure, dopo un’ iniziativa al Museo G.B.Lazagna di Rocchetta Ligure